Divorato.
In due giorni.
Non ci capitava da anni, di esser così avvinti dalla lettura di un libro.
Da non riuscire a staccarsi: neanche in treno, neanche sulla banchina aspettandolo, il treno. Neanche nel foyer aspettando l’inizio di uno spettacolo (e non certo per far l’intellettuale).
Una storia al contrario di Francesca De Sanctis è un libro da leggere per almeno tre motivi.
Primo motivo: perché racconta una storia civile, quella dell’agonia del quotidiano l’Unità, che (ci) dice molto sui tempi che stiamo attraversando, sulla società che stiamo costruendo. E lo fa da dentro, dalla prospettiva di una persona che quelle vicende le ha vissute, toccate. E ne è stata toccata, professionalmente e personalmente.
Secondo motivo: perché racconta, con coraggio inaudito, una storia personale, autobiografica: zeppa fino all’orlo di amore e dolore, di nascite e morti, di malattie e riprese, di soddisfazioni e frustrazioni. Fa ridere e fa commuovere, Una storia al contrario, fa star vicini.
Terzo motivo: perché è un esempio di cristallina arte della narrazione. Ad opera di una giornalista e critica teatrale che sa quel che dice (e scrive) e come dirlo (e scriverlo).
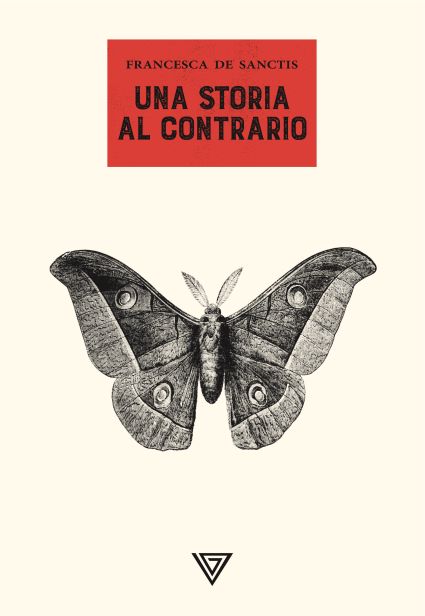
Chi a vario titolo frequenta l’arte della scena ha certo incontrato, e forse condiviso, la “moda” del teatro di narrazione degli ultimi decenni.
Marco Paolini e Ascanio Celestini, forse i più famosi. E Marco Baliani. E Laura Curino, soprattutto in passato. E l’affollata scuola dei pugliesi. E Luigi Dadina del Teatro delle Albe, tra tutti quello che ci è più caro. E tanti, tanti altri. E altre.
Volendo (brutalmente) sintetizzare una molteplicità di stili e mo(n)di, nell’arte della narrazione, occorre nominare alcuni elementi comuni.
Tematicamente: l’intreccio di un pezzo di Storia (spesso dolorosa) con frammenti autobiografici, con storie di persone normali.
Linguisticamente: frasi brevi, molto ritmo, uso del dialetto (o comunque di una Lingua Madre), a render più caldo e personale ciò di cui si tratta.
Scenicamente: pochi elementi, a volte nessuno, a convogliare tutta l’attenzione sulla figura del narratore / della narratrice e sulla vicenda a cui essa dà voce e carne.
Tutto ciò, come accennato, ci sembra emergere con netto vigore dalle pagine di questo libro.
Che, forse non è un caso, sta trovando una sua forma scenica grazie alla maestria di Elena Arvigo, che nei prossimi mesi faremo in modo di seguire e raccontare.

Per concludere, e allargare, questo breve quanto appassionato invito alla lettura introduciamo una grande domanda: come si impara a scrivere (un libro) così?
Forse non ci sono ricette, certo noi non le conosciamo.
Buttiamo lì tre elementi (ingredienti) possibili:
– scrittura come allenamento all’ascolto: da sempre l’autrice si occupa di raccontare / restituire, in quanto giornalista e critica teatrale, frammenti di biografie e opere che incontra. Dall’ascolto degli altri all’ascolto di sé il passo è, se non breve, almeno molto chiaro.
– il valore ideale della scrittura, a partire da quello della testata di cui si raccontano le recenti vicende fino all’impegno militante per un teatro che tenta di essere non solo bello (nozione, come sappiamo, oggi ampiamente soggettiva, dunque opinabile) ma anche utile (nozione, almeno in parte, misurabile)
– scrittura come mestiere: parole che qualcuno deve essere disposto a pagare. Per pubblicarle, per leggerle. E che devono servire a pagar le bollette. Un uso affatto concreto delle parole, dunque. Parole che devono servire a qualcosa: devono essere utili.
Buona lettura a voi.
E chapeau, Francesca.





[…] Magazine, Michele Pascarella https://www.gagarin-magazine.it/2022/03/libri/larte-della-narrazione-su-una-storia-al-contrario-di-f… (21 marzo […]
Comments are closed.