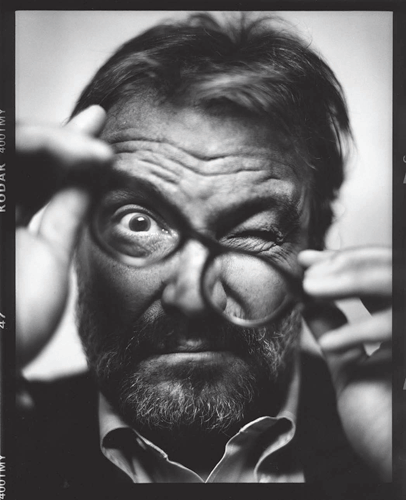Chi mi ama mi segua. Chi ha più di quarant’anni leggendo queste parole forse avrà subito avuto in mente un’immagine precisa, decisamente fuori dai retaggi evangelici. A queste parole, infatti, è indissolubilmente legato l’iconico fondoschiena di una giovane donna – al secolo l’attrice e modella americana Donna Jordan, simbolo della cultura pop tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta – posto in primissimo piano per pubblicizzare un paio di jeans hot-pants della marca Jesus (chi li ricorda?).
Corre il 1973, e siamo nell’Italia piccolo borghese che vive il pieno dell’era democristiana. La polemica monta veloce – al riguardo interviene perfino Pier Paolo Pasolini sulla prima pagina de Il Corriere della Sera – e il manifesto pubblicitario fa il giro del mondo in poco tempo. Fu questo il primo di una lunga serie di successi ma anche di scandali e provocazioni che hanno segnato la carriera di Oliviero Toscani. Allora trentunenne, Oliviero è figlio d’arte, nato da Fedele Toscani, primo fotoreporter per Il Corriere della Sera, nonché cognato di Aldo Ballo, affermato fotografo del design milanese. Nonostante queste influenze, si avvicina alla fotografia non subito, solo dopo una laurea in geografia, perfezionandosi alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, allora tra le più importanti scuole del Vecchio Continente.
Arrivano quindi gli incarichi per le grandi testate internazionali tra cui Esquire, Elle, Vogue, Harper’s Bazar. Nel 1982 prende il via il sodalizio con la casa di moda di Luciano Benetton, durato fino al 2000, che consacra la fama di Toscani definitivamente al grande pubblico con una serie di campagne pubblicitarie – e, possiamo dirlo! – entrate nel mito. In occasione della XIV edizione del Festival di Fotografia Europea, il MAR – Museo d’arte della Città di Ravenna, assieme al Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura, presentano Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti, una mostra a cura di Nicolas Ballario e organizzata dal gruppo Arthemisia.
Non potevamo quindi farci sfuggire l’occasione per fare qualche domanda al grande fotografo milanese, partendo subito da una prima e importante curiosità. Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti è stata presentata come la sua prima antologica in un museo italiano e mi chiedo il perché di questo grande ritardo: una scelta precisa da parte sua (o di altri)? «Questa mostra non è mia, ma delle persone che hanno voluto organizzarla. È una vita che faccio mostre sui muri e i giornali del mondo, perché credo che la fotografia vada mostrata così, e sono molto curioso di sapere cosa gli altri fanno delle mie foto ora che sono inutili. Forse quando le foto diventano inutilizzabili, diventano foto d’arte».
Crede che questo ritardo sia dovuto a una precisa volontà o mancanza da parte della critica italiana? Ci sono aspetti che sente sottovalutati della sua ricerca? «Non mi interessa criticare la critica».
A proposito del fallimento, che è poi il tema attorno a cui ruota questa mostra, qual è il significato che riveste nel suo lavoro? «Il fallimento è energia per fare meglio. È inteso come critica per andare avanti».
Nelle oltre 150 opere che ripercorrono i cinquant’anni della sua carriera come fotografo, il confine tra arte e moda è spesso oltrepassato, confuso, quanto meno reso molto labile. Qual è il rapporto tra questi due linguaggi espressivi? «Penso che quando la moda è fatta in modo qualitativo può essere arte. L’arte è l’eccellenza della comunicazione».
I libri ci insegnano che l’avanguardia passa sempre attraverso una rottura, una provocazione. Lei si sente un po’ come l’ultimo artista realmente d’avanguardia rimasto nel nostro Paese? «Non saprei fare una classifica e definire quanti provocatori ci siano in circolazione. È indubbio che per cercare nuove espressioni occorre provocare. La parola provocare stranamente ha una connotazione negativa, mentre io trovo sia estremamente positiva: si può provocare un pensiero, l’amore, la pace, la cultura e tante cose stupende».
I recenti fatti di Verona, lo spettro del decreto Pillon, le morti nel Mediterraneo, la xenofobia che cresce, una politica nazionale sempre più becera e qualunquista, ci parlano di quarant’anni di diritti e conquiste civili che oggi sono sempre più minacciati nel loro insieme e rischiano di far piombare l’Italia in un nuovo periodo oscurantista e razzista. Lei che ha sempre giocato su perbenismi e contraddizioni della società italiana impegnandosi in prima persona anche politicamente, che opinione ha del nostro Paese oggi? «Siamo un Paese mediamente ignorante. Il razzismo viene da lì. Non siamo razzisti, siamo ignoranti. D’altronde più una civiltà progredisce e più è richiesta una cultura elevata. Una volta si poteva essere bravi contadini anche essendo analfabeti, oggi non basta più. Il paradosso è che oggi è pieno di analfabeti persino in politica».
A questo punto non posso esimermi da farle una domanda più specifica: secondo lei l’arte ha una precisa responsabilità politica? «È soprattutto un’espressione socio-politica. Se non contiene questo aspetto non è arte, ma compiacimento estetico».
Lei ha descritto con il candore dell’arte la ferocia della società contemporanea, le sue contraddizioni e la sua violenza. Ha parlato di guerra, razzismo, AIDS, pena di morte, anoressia e ogni volta l’ha fatto senza compromessi e perbenismi, riuscendo a scuotere le coscienze anche grazie a una divulgazione di massa del suo lavoro che pochi altri artisti possono vantare. Penso ad alcuni dei lavori in particolare, oggi ritenuti iconici, alcuni dei quali presenti nella mostra al Mar di Ravenna, come il Bacio tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, e il più recente No-Anorexia del 2007. Tutte opere accompagnate da feroci polemiche. Mi sono sempre chiesto, qual è, per lei, il senso della censura? Una sfida o una conferma del suo valore? «La censura è per me la paura delle nuove espressioni. È la conseguenza di un potere, quello di un gruppo di persone che non vogliono affrontare l’evoluzione. Qualunque essa sia».
Oltre al lato impegnato e politico, il suo lavoro ha anche un aspetto importante legato appunto alla moda e al glamour. Davanti al suo obiettivo sono passati decine di uomini, tra i più grandi personaggi e i protagonisti della cultura del XX secolo. Tra tutti, chi ricorda con maggiore entusiasmo? «Muhammad Ali e Bob Dylan».
In conclusione del nostro incontro le faccio una domanda, un po’ retorica, ma che credo possa avere un senso soprattutto perché è lei a rispondere. Quale consiglio darebbe a un giovane che oggi si avvicina alla fotografia? «Ormai siamo tutti vicini alla fotografia. Fotografare è come guidare l’automobile: tutti abbiamo la patente e un mezzo a disposizione, poi ci sono gli autisti della domenica e i piloti di Formula 1. Il primo consiglio è: qualunque sia la vostra strada, cercate di non sbandare».