Dalla mostra di Gianluigi Colin al Palazzo del Governatore di Parma all’Amleto di Michele Sinisi visto al Teatro Testori di Forlì. Da Picasso. La sfida della ceramica al MIC di Faenza al saggio Che cos’è la video-estetica di Alessandro Alfieri (Roma, Carocci, 2019): note su alcune belle occasioni per nutrire la rivoluzione degli / negli occhi.
Da ragazzino – potevo avere undici o dodici anni – se vedevo un funerale, immediatamente mi accodavo. Poi, piano piano, m’intrufolavo fino ad essere vicino ai parenti del morto; assumevo un’aria afflitta e fingevo di commuovermi fino alle lagrime, per farmi compatire dalla gente.
– Povero figlio…
– Quanto mi fa pena…
– Chi sarà?…
– Sarà un nipote…
– No; deve essere il figlio…
– Ma non aveva figli…
– Allora sarà il figlio del portiere di casa sua…
– Non credo. Guardalo come piange…
– Ma chi è? Sarà il figlio di sua sorella…
– Sarà il figlio della serva…
– Tu lo conosci? Ma di chi è figlio?
– Sarà il figlio della colpa…
Tutte queste cose veramente non le dicevano: io, però, m’immaginavo che le dicessero.
Ma perché facevo tutto questo?
Facevo il teatro.
L’incipit del gustoso libretto di memorie Modestia a parte… di Ettore Petrolini (Bologna, Cappelli, 1932) pare perfetto per dare avvio a un pur veloce resoconto di alcune forme culturali in cui ci siamo imbattuti nelle ultime settimane, diverse per medium utilizzato eppure accomunate da una medesima interrogazione alla postura (del) guardante nello smuovere con diversi gradi di ironia (dunque, socraticamente, di distanza) il rapporto dell’immagine con il proprio farsi.
Due mostre, uno spettacolo e un libro: tutti lì a «guardarsi guardare», per dirla con Merleau-Ponty.
Immagini che interrogano immagini.
L’argomento, va da sé, è smisurato, la ricchezza di pensiero ed esperienza di cui queste proposizioni sono traccia affatto imponente: non v’è dunque alcuna pretesa di esaustività, in queste poche righe, solo il desiderio di restituire per lacerti e lampi alcune visioni, come semplice invito a costruirne di personali.
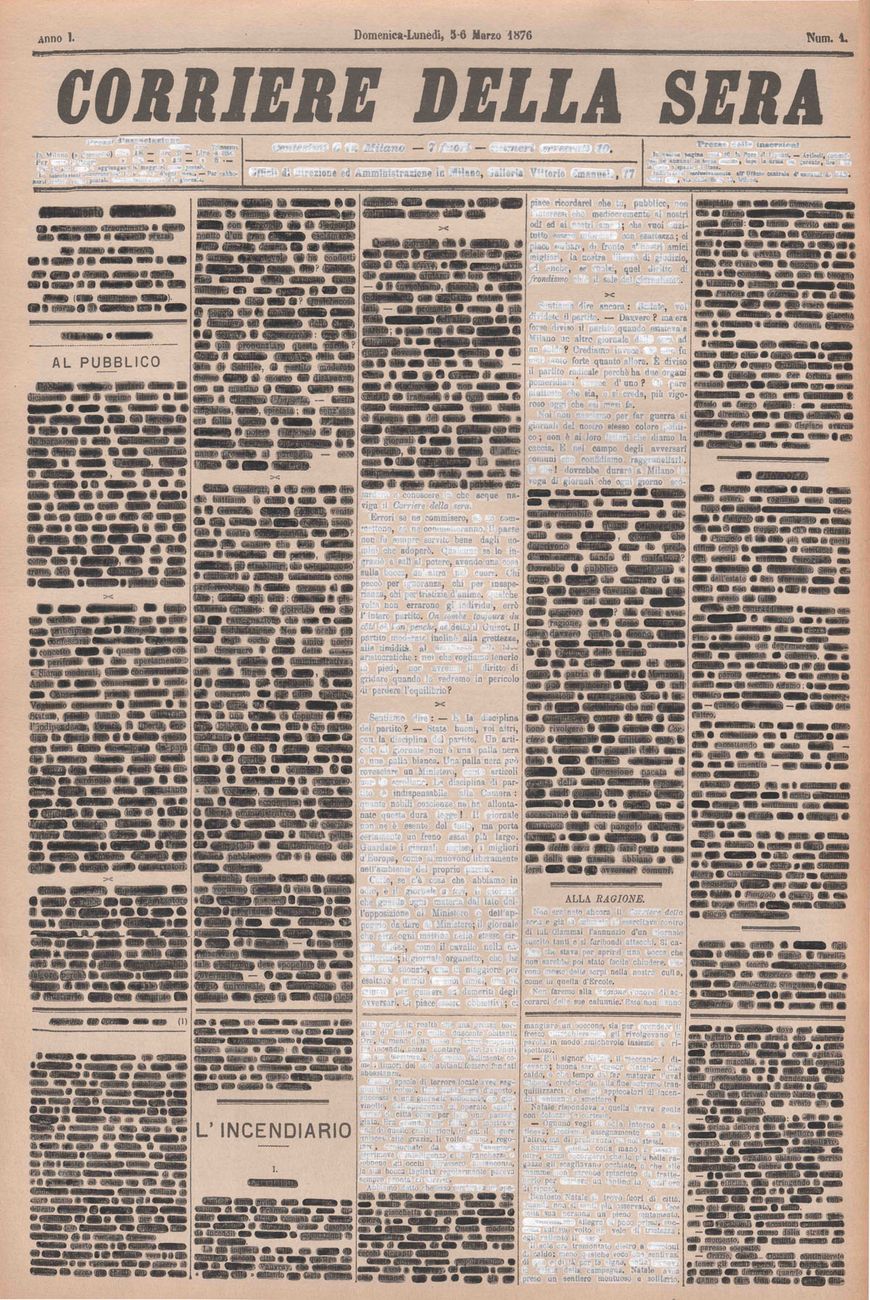
Al Palazzo del Governatore di Parma abbiamo visitato, nel penultimo giorno di apertura, la mostra Costellazioni Familiari – Dialoghi sulla libertà, che ha messo in forma di immagine gli stratificati rapporti dell’artista visivo ed «agitatore culturale» Gianluigi Colin con giganti del calibro di Getulio Alviani, Nanni Balestrini, John Berger, Mario Dondero, Emilio Isgrò, Jannis Kounellis, Mimmo Paladino, Claudio Parmiggiani, Mimmo Rotella, Mario Schifano, Federico Tavan e Franco Vaccari, tra gli altri.
Oggetto dell’esposizione, nomen omen, sono state le fecondanti reciproche citazioni (termine da intendersi come attitudine a inserire l’altrui discorso nel proprio, modificandone segno e significato) che le diverse biografie artistiche hanno generato.
Tema specifico di indagine: il rapporto fra immagine e parola, che nel caso dell’occasione parmigiana si è inverato in almeno due precise direzioni.
La prima: opere che (rap)presentano parole, elidendole. Da Kounellis che con una larga pennellata nera copre la scritta «W la libertà W Gericault» in apertura fino alle celebri cancellature di Isgrò, passando dalle traps dello stesso Colin in cui decine di trappole per topi sparse sul pavimento imprigionano alcune parole-simbolo dell’oggi, tratte da pagine di giornali americani.
La seconda: in aggiunta alle consuete didascalie (con nome dell’autore, titolo, tecnica utilizzata, data e misure) a quasi tutte le opere è giustapposta una piccola narrazione in prima persona in cui Colin racconta l’occasione della creazione dell’opera e/o il proprio personale rapporto con l’artista. «In un giorno di primavera del 2014, con Maria Nadotti sono andato a trovare John Berger nella sua fattoria nello sperduto villaggio di Quincy, sotto il Monte Bianco»: così inizia ad esempio la nota a fianco di Texte d’oignon del geniale critico, scrittore e artista inglese che «il giorno prima aveva invitato un vicino a far nascere un vitello».
Al di là del gusto per l’aneddoto e l’ineludibile rete di relazioni che si origina in qualsivoglia società o consorzio umano, pare interessante notare come questa rigorosa e complessa ricerca artistica si nutra di mondo -non solo di accademia- e l’opera non si pone tanto come rappresentazione del mondo (o della vita), quanto come un suo peculiare frammento.

Un po’ come il Petrolini citato in apertura, anche l’Amleto di Michele Sinisi, visto al Teatro Testori di Forlì, gioca senza posa con la percezione del reale.
A partire dal capolavoro di Shakespeare, lo spettacolo ingaggia una dinamica «ludica» di relazione con le aspettative dei guardanti, resa possibile dall’estrema notorietà del testo di partenza. In questo «gioco delle variazioni», in cui il dato di interesse proviene non dal ricevere una immagine (o storia) sconosciuta, quanto dal vedere come viene raccontata una vicenda già nota, Sinisi dà ennesima prova di grande istrionismo, termine qui da intendersi in senso etimologico del prevalere del corpo e della cinesi sulla parola.
È infatti attraverso il movimento che la molteplicità di Figure che abitano il testo prendono vita, in una scena composta unicamente di alcune sedie (sui cui schienali è scritto brutalmente il nome dei personaggi), un telefono cellulare con cui l’attore di tanto in tanto fa ascoltare una musica e un po’ d’acqua.
In questo Amleto l’artista pugliese propone suoi consolidati stilemi: abbassamento del lirismo nella direzione della colloquialità, uso di oggetti pop, picchi improvvisi del volume della voce, cadenza dialettale, dialettica fra presentazione e rappresentazione, messa in evidenza del dispositivo e della lingua scenica, reiterazioni per creare tensione drammatica oggettiva, ecc.
In questo esercizio di re-citazione (dunque di ri-nominazione), al centro del teatro che ciascuno spettatore va costruendosi nella mente sta la distanza tra ciò che si sa e ciò che è dato a vedere – in tal senso pare appropriata la scelta di restituire la vicenda per frammenti, con un senso della variazione a farsi decostruzione, più che mera esibizione di inventiva.
Sinisi senza posa sfila / smonta davanti agli occhi dello spettatore ciò che vede e sa, con un’attitudine che se altrove abbiamo definito post-drammatica in questo caso potremmo nominare almeno post-moderna.

Al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza abbiamo visitato la mostra Picasso. La sfida della ceramica (visitabile fino al 13 aprile 2020), in cui sono esposti cinquanta pezzi unici provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso-Paris.
Raccomandando con forza al lettore di cogliere l’occasione per visitare la straordinaria collezione permanente del MIC, che raccoglie fascinosi manufatti di un’ampissima gamma di provenienze ed epoche, la mostra dedicata al celeberrimo artista spagnolo pare aggiungere al piccolo discorso sull’immagine che stiamo approntando in queste righe un’ulteriore esemplificazione.
Posta la dimensione economico-commerciale di una produzione affatto distante da ogni pretesa romantica di arte come insopprimibile necessità di espressione del sentimento (con l’aiuto fondamentale del ceramista Jules Agard al tornio, Picasso nel solo anno 1948 ha creato ben 2.000 pezzi unici ceramici – ai quali vanno aggiunti gli altri circa 3.000 creati successivamente e la gran quantità di multipli), le opere in mostra a Faenza rispondono ad almeno due logiche, nel rapporto con l’immagine.
La prima: in alcuni casi Picasso utilizza il supporto come fosse una tela (fino a dipingere sui bordi i chiodi che normalmente fissano questo tessuto alla cornice di legno), ponendo di fatto una distanza tra l’immagine ed il medium utilizzato.
La seconda: dal materiale scaturisce l’immagine, come nel caso di una bottiglia che, ritorta, diviene colomba.
Ai fini del nostro discorso questa trasformazione (da bottiglia a colomba) è utile in quanto pertiene la non identità tra estetico e artistico.
Se è vero che gli oggetti estetici includono sia gli elementi naturali che gli artefatti, un’opera d’arte non è che un artefatto a funzione estetica la cui qualifica è data da una relazione.
Detto altrimenti: qualsiasi oggetto può risultare estetico per un soggetto, ma nessun oggetto può dirsi artistico in sé.
Ancor meglio: affinché un oggetto possa dirsi opera d’arte occorrono 1) la volontà dell’autore 2) un sistema sociale che lo qualifichi come tale 3) una sufficiente attenzione e disposizione del fruitore per accoglierlo.
Un’analoga «bottiglia ritorta» vista altrove (e non in un Museo) sarebbe egualmente classificabile come opera d’arte?
Al di là delle sempre opinabili risposte, crediamo di interesse l’invito dell’occasione faentina a «guardarsi guardare» l’arte e il mondo.
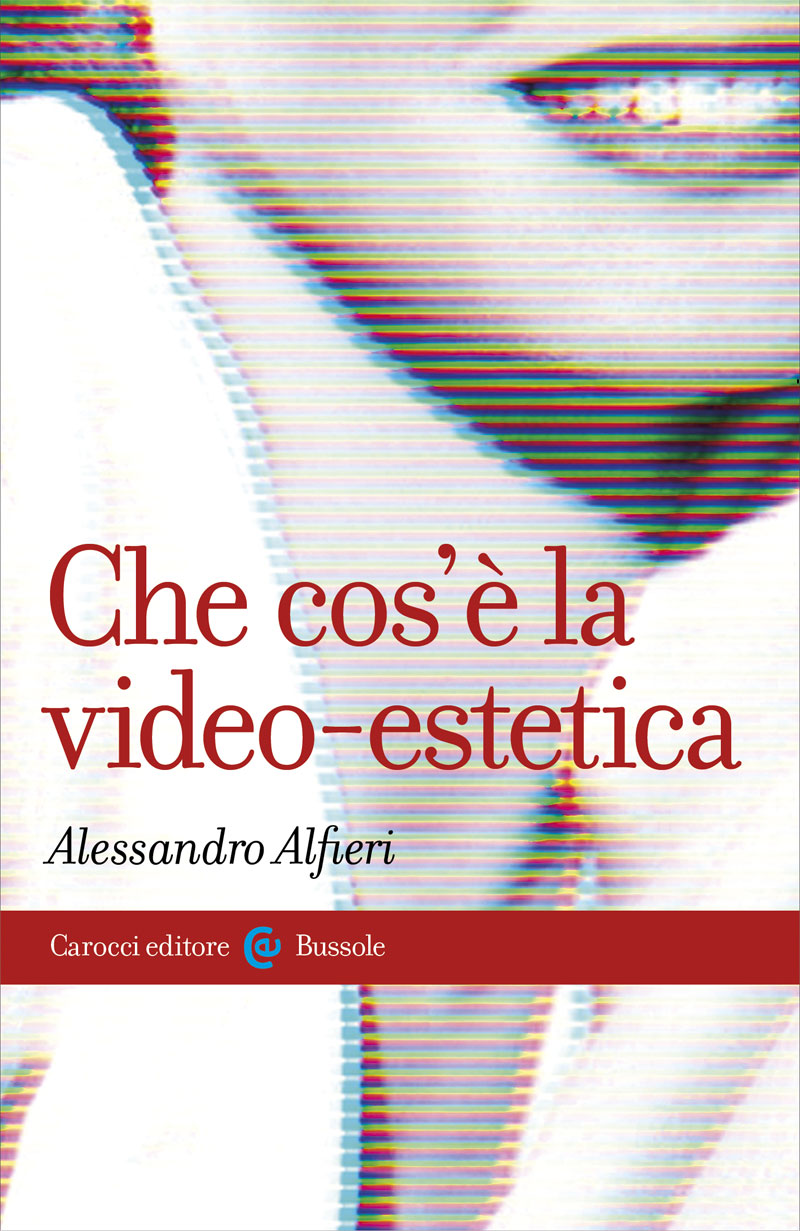
Di questi ed altri temi, con profondità e ampiezza impossibili da riassumere qui, si occupa il recente Che cos’è la video-estetica di Alessandro Alfieri (Roma, Carocci, 2019).
Il saggio con visionario rigore analizza, con una quantità di esempi e riferimenti, i rapporti reciprocamente nutrienti tra ricerca artistica e settori commerciali, in special modo nell’ambito dei videoclip musicali, studiando «lo strano rapporto schizofrenico e irrisolto tra sperimentazione audiovisiva e applicazione commerciale nel settore videomusicale» (p.97).
A partire da un sintetico ma certo indispensabile inquadramento storico, che fa originare la video arte nel movimento Fluxus (anni Cinquanta / Sessanta) che si poneva in continuità con il Dadaismo di inizio Novecento, il saggio analizza il lavoro di diversi autori con una ampiezza di riferimenti e di sguardo da renderlo di grande interesse non solo per gli appassionati del settore o per gli addetti ai lavori, ma per tutti coloro che si trovano a guardare le forme (culturali) del mondo: cioè tutti.
Mandando al diavolo la consueta quanto sterile distinzione tra cultura alta e bassa, tra ciò che è arte e ciò che arte non è, il saggio di Alessandro Alfieri propone una salutare rivoluzione dello sguardo: «La totale assuefazione e il radicale intorpidimento nei confronti dell’orizzonte massmediale sembrano essersi compiuti proprio quando, come accade oggi, l’arte stessa, deputata storicamente alla comprensione critica del mutamento antropologico derivante dagli sviluppi tecnologici, rinuncia a questa sua funzione, preferendo rispecchiare la realtà instaurando un circolo di perpetua identità: il capovolgimento dialettico e paradossale è che proprio l’arte, che ambisce più di ogni altra espressione culturale a recuperare l’esperienza della Avanguardie storiche, che si affida all’assolutizzazione della forma e dell’autonomia e che intende opporsi all’odierno orizzonte-socio-culturale attraverso la forza dell’isolamento, in realtà ottiene proprio il risultato di mantenere lo stato delle cose (arrivando persino ad abbellirle tramite l’ornamentalità), mentre la forza veritativa e critica viene recuperata, dialetticamente, negli episodi culturali nei quali la sperimentazione dell’arte digitale ha trovato ambiti applicativi appartenenti alla dimensione della popular culture» (pp. 66-67).
Quattro occasioni per nutrire la rivoluzione degli / negli occhi.
Dire grazie, almeno.
MICHELE PASCARELLA
info: https://www.comune.parma.it/cultura/evento/it-IT/Mostra-Costellazioni-Familiari-Dialoghi-sulla-liberta.aspx, http://www.colin.it/, https://www.teatrotestori.it/, https://www.facebook.com/michele.sinisi.9, http://www.micfaenza.org/it/mostre/394-picasso-la-sfida-della-ceramica.php, https://www.facebook.com/alessandro.alfieri.129, http://www.carocci.it/




