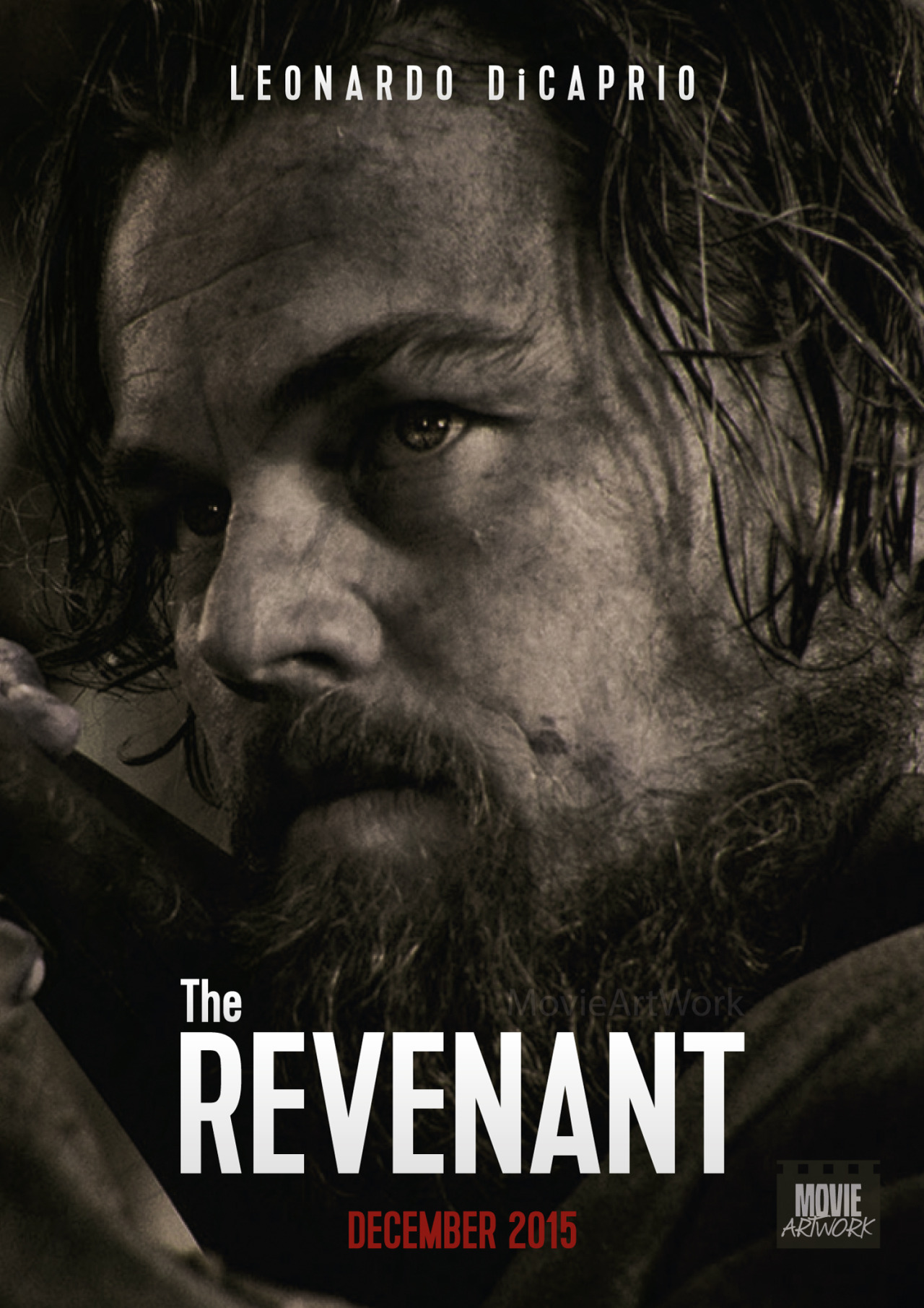Chi volesse trovare una linea di continuità nel cinema di Alejandro Gonzáles Iñárritu, dall’esordio Amores Perros (2000) a quest’ultimo Revenant – Redivivo (The Revenant), passando per la pioggia di Oscar caduta su Birdman, O L’Imprevedibile Virtù Dell’Ignoranza (Birdman, Or The Unexpected Virtue Of Ignorance, 2014), dovrebbe per forza cercarla nella costanza con cui il regista messicano ha tentato, a ogni nuovo lavoro, di sviluppare, plasmare e contraddire i limiti tecnici della messinscena attraverso modalità di ripresa sempre più impegnative e complicate. Dopo il singolo piano-sequenza – un’unica inquadratura della durata di un film ambientato dentro e fuori i corridoi di un teatro di Broadway – di Birdman (in realtà composto da tante inquadrature, comunque estremamente sofisticate, legate tra loro da fotogrammi fissi o immagini buie) questa volta la videocamera Arri, modello Alexa 65, dello straordinario Emmanuel “Chivo” Lubezki (tra i più grandi cineoperatori viventi, se non “il” più grande) si proietta nel Montana e nel Dakota di fine ‘800, ricreati tra Canada occidentale, Stati Uniti e Argentina (in modo da seguire il depositarsi della neve) per girare alcune delle riprese più virtuosistiche mai viste sul grande schermo. Rispetto a quelli di Revenant, il piano-sequenza di Birdman sembra, oggi, un gioco da ragazzi svogliati: pur non avendoli cronometrati, delle centinaia di piani-sequenza del film, mai al di sotto dei due minuti, almeno due, ossia l’iniziale attacco indiano alle spedizione dei cacciatori di pellicce e l’aggressione dell’orso ai danni del protagonista, durano rispettivamente 4’ e 6’ (anche se nel secondo potrebbero esserci due “trucchi” di cucitura tra sequenze differenti), e risultano a dir poco prodigiosi dal punto di vista della forma. Lubezki vi abita, si muove, volteggia con la foga dello sbarco in Normandia nel primo caso, e rimane appiccicato alla pelle, alla pelliccia, alle zampe, alla bava, alle unghie, ai fiotti di emoglobina e alle ossa dei due “animali” – l’uomo e il grizzly – nel secondo, finché entrambi non scivolano in un crepaccio (dove la mdp continua a inseguirli in una verticale discendente, movimento poi ripetuto quando un destriero e il suo cavaliere precipitano in un burrone), come se volesse costruire una vera e propria polifonia dello sguardo, esteso, allucinato, abbacinato al limite della sopportazione delle palpebre.
Chi volesse trovare una linea di continuità nel cinema di Alejandro Gonzáles Iñárritu, dall’esordio Amores Perros (2000) a quest’ultimo Revenant – Redivivo (The Revenant), passando per la pioggia di Oscar caduta su Birdman, O L’Imprevedibile Virtù Dell’Ignoranza (Birdman, Or The Unexpected Virtue Of Ignorance, 2014), dovrebbe per forza cercarla nella costanza con cui il regista messicano ha tentato, a ogni nuovo lavoro, di sviluppare, plasmare e contraddire i limiti tecnici della messinscena attraverso modalità di ripresa sempre più impegnative e complicate. Dopo il singolo piano-sequenza – un’unica inquadratura della durata di un film ambientato dentro e fuori i corridoi di un teatro di Broadway – di Birdman (in realtà composto da tante inquadrature, comunque estremamente sofisticate, legate tra loro da fotogrammi fissi o immagini buie) questa volta la videocamera Arri, modello Alexa 65, dello straordinario Emmanuel “Chivo” Lubezki (tra i più grandi cineoperatori viventi, se non “il” più grande) si proietta nel Montana e nel Dakota di fine ‘800, ricreati tra Canada occidentale, Stati Uniti e Argentina (in modo da seguire il depositarsi della neve) per girare alcune delle riprese più virtuosistiche mai viste sul grande schermo. Rispetto a quelli di Revenant, il piano-sequenza di Birdman sembra, oggi, un gioco da ragazzi svogliati: pur non avendoli cronometrati, delle centinaia di piani-sequenza del film, mai al di sotto dei due minuti, almeno due, ossia l’iniziale attacco indiano alle spedizione dei cacciatori di pellicce e l’aggressione dell’orso ai danni del protagonista, durano rispettivamente 4’ e 6’ (anche se nel secondo potrebbero esserci due “trucchi” di cucitura tra sequenze differenti), e risultano a dir poco prodigiosi dal punto di vista della forma. Lubezki vi abita, si muove, volteggia con la foga dello sbarco in Normandia nel primo caso, e rimane appiccicato alla pelle, alla pelliccia, alle zampe, alla bava, alle unghie, ai fiotti di emoglobina e alle ossa dei due “animali” – l’uomo e il grizzly – nel secondo, finché entrambi non scivolano in un crepaccio (dove la mdp continua a inseguirli in una verticale discendente, movimento poi ripetuto quando un destriero e il suo cavaliere precipitano in un burrone), come se volesse costruire una vera e propria polifonia dello sguardo, esteso, allucinato, abbacinato al limite della sopportazione delle palpebre.

Ma anche senza soggettive, la camera di Lubezki incarna pur sempre l’occhio demiurgico di Iñárritu, la sua voglia di sperimentare con gli elementi dell’alchimia visuale, il suo desiderio di rendere lo spettatore partecipe dell’agonia fisica degli attori (nel corpo a corpo finale sulle lenti della cinepresa schizzano, offuscandola, sudore, sputi e sangue) e la loro difficoltà nel dimorare il paesaggio (mezza troupe è stata a rischio costante d’ipotermia) e polarizzarne le luci (avendo effettuato le riprese con scenari e radiazioni naturali, la finestra di tempo utilizzabile di giorno in giorno è stata spesso molto ridotta). Detto questo, Iñárritu non è il primo a sfruttare la macchina a mano con impazienza febbricitante, perché prima di lui abbiamo avuto i movimenti tarantolati di Aleksei German e Andrzej Żuławski, Arca Russa (Russkij Kovcheg, 2002) di Aleksandr Sokurov, la marcia inarrestabile e frastornante del cineobiettivo in un capolavoro come Le Ombre Degli Avi Dimenticati (Tini Zabutykh Predkiv, 1965) di Sergej Paradžanov oppure, per proporre esempi meno altisonanti, il piano sequenza da 7’ che apre Breaking News (2004) di Johnnie To e quello, altrettanto lungo, in conclusione a Professione Reporter (1975) di Michelangelo Antonioni (ma anche la scena di ballo al centro dello Sguardo Di Ulisse [To Vlemma Tou Odyssea, 1995] di Théo Angelopoulos è un piano-sequenza da sette minuti). Persino l’ormai celeberrima long-take di Birdman, da 119’, è stata oltrepassata, l’anno scorso, dal tedesco Victoria (2015) di Sebastian Schipper, 138’ di inquadratura unica, senza stacchi di montaggio. In tutto questo minestrone di riferimenti, la domanda resta una sola, e cioè se questi acrobatici sfoggi di bravura siano in grado di trascendere la dimensione dell’esercizio, ancorché prestigioso, di pura accademia.

Iñárritu e il suo co-sceneggiatore Mark L. Smith prendono le mosse dal romanzo omonimo di Michael Punke (2002, uscito da noi, per i tipi di Einaudi, due anni fa), rivisitazione quasi documentaria dell’odissea vissuta da Hugh Glass, trapper nell’estate del 1823 abbandonato dai suoi compagni di lavoro (lo credevano morto) e invece miracolosamente sopravvissuto e intenzionato a sostenere un viaggio solitario di 3’000 miglia per vendicarsi (vicenda già alla base del modesto Uomo Bianco Và Col Tuo Dio [Man In The Wilderness, 1973] di Richard C. Sarafian, con Richard Harris nei panni del personaggio modellato su Glass). Arruolato Leonardo Di Caprio nel ruolo di Glass e l’inglese Tom Hardy in quello del suo collega e nemesi John Fitzgerald, e facendo assumere a quest’ultimo un alone mefistofelico assente dal libro di Punke, regista e sceneggiatore hanno aggiunto al protagonista un figlio di origine Pawnee e un passato controverso presso una tribù di pellerossa, due espedienti sfruttati da Iñárritu per appesantire il racconto con ricordi e visioni improntate a un frullato del misticismo tipico delle culture dei nativi d’America, col risultato di ridurre un apparato di pensiero filosofico e animista a qualche immagine kitsch alla maniera del Terrence Malick (altro assistito di Lubezki) più speculativo, umorale, inafferrabile, ma senza la sua fiducia nella capacità del cinema di esprimere l’indicibile e l’incorporeo. Revenant – Redivivo, al contrario, rinuncia a ogni tentazione ideale per immergersi in un continuo sovraccarico: di rappresentazioni grafiche della violenza, di sangue rossastro in contrapposizione al candore ostinato della neve (che tutto avvolge come un sudario di ghiaccio), di esangui apoteosi estetiche della confezione iconografica.
 L’ultimo quarto d’ora del film si discosta anch’esso dalla conclusione in anti-climax del romanzo per allineare l’ennesima parata di abilità ginniche dove, ancora una volta, Iñárritu non riesce a ghermire e scarnificare l’essenza del vivere per ribaltarla nelle immagini, limitandosi altresì a predisporre con indiscutibile maestria fotogrammi tanto ricercati quanto vuoti, privilegiando in ogni circostanza l’esibizione all’ellissi. Revenant – Redivivo non riesce mai a qualificare il cinema come luogo di esperienza e di conoscenza al di là dell’involucro perfetto mediante il quale è costruito: nonostante tutti gli urli, le grida e le espettorazioni fornite alla causa da un Di Caprio mai così generoso nel mettersi alla prova e nel subìre torture di ogni genere, la vera energia e il vero dinamismo del film risiedono nelle mute vastità dei panorami, soffocanti e oppressivi, terribili e soverchianti anche se incapaci di emettere un solo suono (e difatti la partitura minimalista composta per l’occasione dal giapponese Ryuichi Sakamoto e dal tedesco Alva Noto con la collaborazione di Bryce Dessner, chitarrista dei National, si fa più spessa e solenne col procedere della narrazione). Fino a trasformare la pellicola in uno di quei prodotti di fronte ai quali si manifesta tiepida ammirazione e nessun affetto.
L’ultimo quarto d’ora del film si discosta anch’esso dalla conclusione in anti-climax del romanzo per allineare l’ennesima parata di abilità ginniche dove, ancora una volta, Iñárritu non riesce a ghermire e scarnificare l’essenza del vivere per ribaltarla nelle immagini, limitandosi altresì a predisporre con indiscutibile maestria fotogrammi tanto ricercati quanto vuoti, privilegiando in ogni circostanza l’esibizione all’ellissi. Revenant – Redivivo non riesce mai a qualificare il cinema come luogo di esperienza e di conoscenza al di là dell’involucro perfetto mediante il quale è costruito: nonostante tutti gli urli, le grida e le espettorazioni fornite alla causa da un Di Caprio mai così generoso nel mettersi alla prova e nel subìre torture di ogni genere, la vera energia e il vero dinamismo del film risiedono nelle mute vastità dei panorami, soffocanti e oppressivi, terribili e soverchianti anche se incapaci di emettere un solo suono (e difatti la partitura minimalista composta per l’occasione dal giapponese Ryuichi Sakamoto e dal tedesco Alva Noto con la collaborazione di Bryce Dessner, chitarrista dei National, si fa più spessa e solenne col procedere della narrazione). Fino a trasformare la pellicola in uno di quei prodotti di fronte ai quali si manifesta tiepida ammirazione e nessun affetto.
Gianfranco Callieri
REVENANT – REDIVIVO
Alejandro Gonzáles Iñárritu
Usa – 2015 – 156’
voto: **1/2