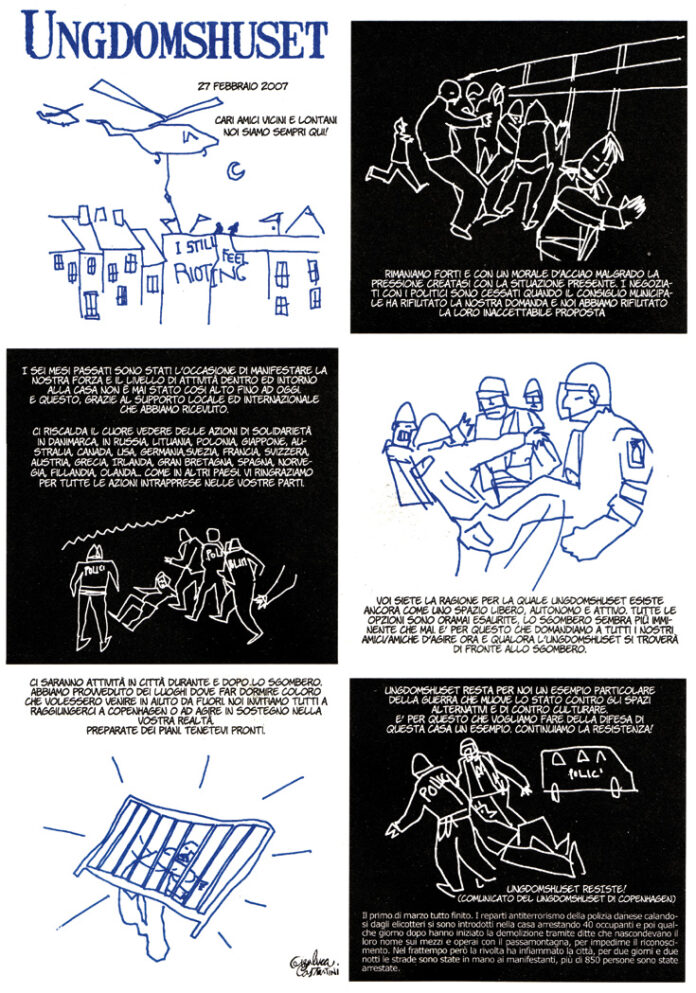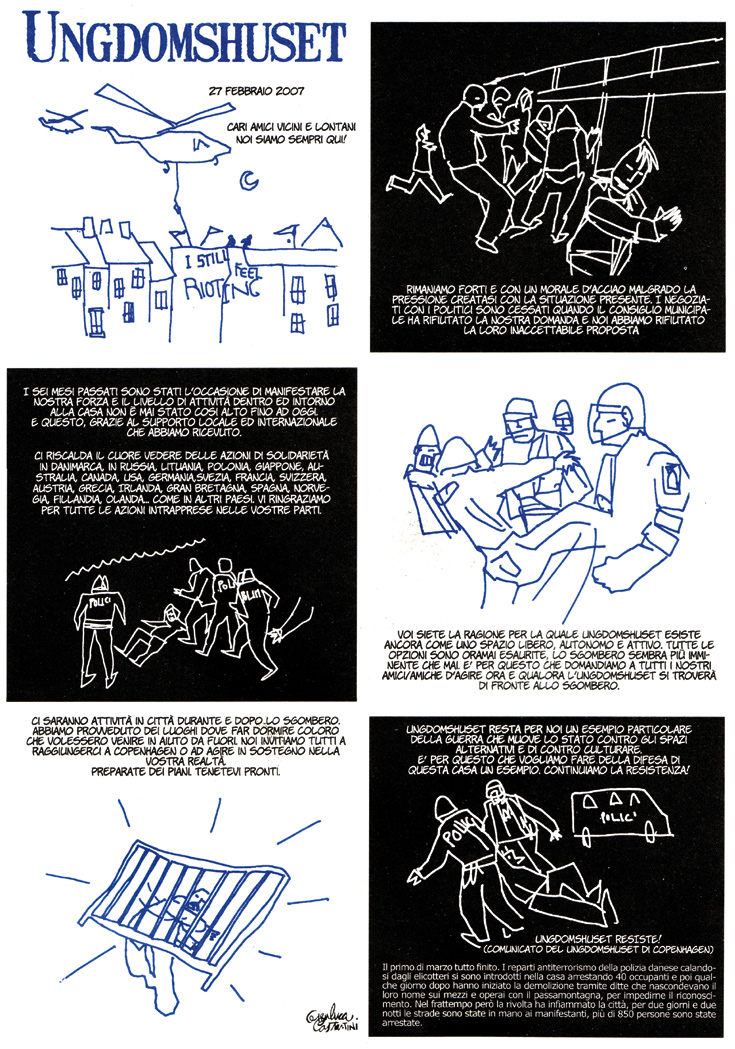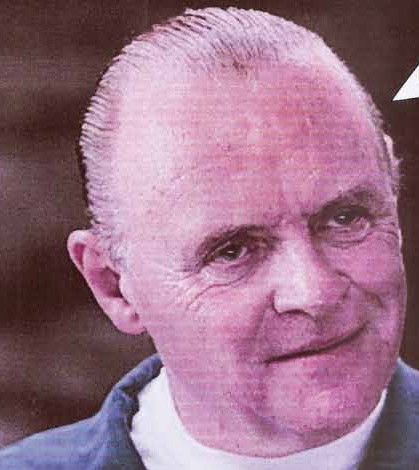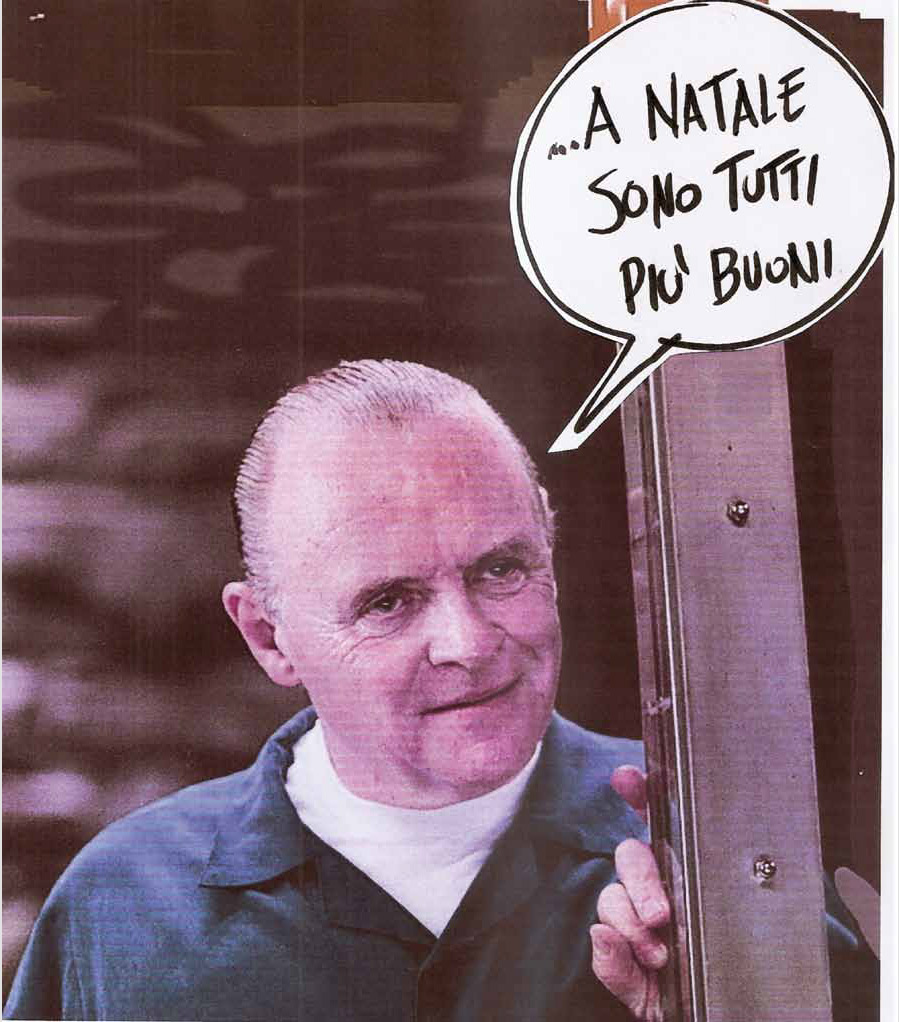Era la fine di maggio 2009 quando con mia moglie decidemmo di intraprendere la grande avventura di adottare un bambino. Lo ricordo molto bene anche per un altro importante momento, purtroppo doloroso, della mia vita. Nello stesso periodo mio babbo, già segnato da un’età avanzata, si ammalò gravemente fino alla fine che avvenne in neanche due mesi. Riuscii però ad accennargli di questa cosa che volevamo fare. Lui non parlava già più, ma capiva ancora bene: come fosse ora ricordo che alzò un dito e disse l’ultima parola che io sentii da lui…

Una volta negli uffici dei Servizi Sociali del nostro Comune per iniziare l’iter dell’adozione capiamo fin da subito che avremmo dovuto armarci di pazienza: la questione sarebbe stata lunga. Partiamo quindi col piede giusto, quello di sapere che ci vorranno almeno tre anni per arrivare al traguardo di diventare genitori. I passaggi per ottenere il via libera dai servizi sociali (il corso ed i vari incontri personali, la fatidica relazione positiva) e poi l’ok del Tribunale dei Minori non comportano particolari problemi, anzi, se non quello di portarsi via un anno e mezzo.
Nel frattempo cerchiamo un Ente a cui rivolgerci per poter fare un’adozione internazionale. Avevamo deciso in questa maniera: avremmo potuto fare la scelta delle adozioni nazionali, ma un po’ per come l’abbiamo vista fin dall’inizio, un po’ perché pare essere ancor più lunga della internazionale, un po’ non sappiamo neanche noi… Siamo andati in questa direzione. Dopo ore su internet gli Enti da noi scelti sono tre. Partecipiamo ai loro incontri conoscitivi e una volta scelto quello a cui appoggiarci diamo il mandato dopo aver fatto il primo corso utile nella nostra Regione (altri 4 mesi se ne sono andati).
Se in principio impari cose interessanti e a cui magari non avevi pensato, con lo psicologo dei servizi sociali che ti affetta un po’ come il burro, sei comunque ancora lontano dalla meta e quasi tutto questo ricade nella categoria «in un certo senso ce lo aspettavamo». Ora invece si inizia a fare sul serio: il livello emotivo viene sollecitato in maniera importante. Le prime simulazioni fatte con l’Ente, i filmati molto crudi che ti vengono messi sotto gli occhi ti fanno uscire dalla cosa bella che stai facendo e ti proiettano nelle difficoltà che dovrai affrontare. Tuttavia anche questo si può superare se il convincimento di partenza è onesto così come il decidere sempre assieme.
A questo punto non resta che attendere l’abbinamento con il bambino. Sappiamo che può volerci un anno ma… colpo di fortuna: dopo circa sei mesi ci chiamano per un abbinamento. Andiamo a Firenze per visionare la scheda ed accettare il percorso del nostro futuro figlio.
Qui comincia il macello emotivo.
In cinque minuti seduti su una sedia guardiamo una foto, leggiamo una scheda e siamo chiamati a dare una risposta che cambierà la nostra vita. Mia moglie si commuove, io sono dietro di lei un po’ al buio e così riesco a nascondere le mie emozioni. Pudore che andrà poi a farsi benedire. Dubbi? Certamente, ma siamo determinati ad accettare ed accettiamo. Il viaggio di ritorno a Faenza con mia moglie è velato da un sentimento così profondo di condivisione e amore che neanche il giorno del nostro matrimonio abbiamo provato. Abbiamo una bambina siberiana.
Dopo un altro paio di mesi arriva la notizia del nostro primo viaggio per fine marzo vicino a Novosibirsk, Siberia. Ah, vicino da quelle parti è un’unità di misura della distanza che equivale a circa 500 chilometri (sette ore in taxi o dodici di treno). Conoscere la bambina è un’emozione di un’intensità che non potevo attendermi. Ciò nonostante ci avvertono: non bisogna commuoversi perché la bimba potrebbe fraintendere. Men che mai un uomo. Un russo che piange non si è mai visto. Così le cataratte si sono rotte solo a sera nella nostra camera, quando io e mia moglie, finalmente soli, ci siamo potuti sfogare. Ho dormito un paio d’ore, lei nemmeno quelle.
Dopo alcuni giorni ripartiamo per l’Italia, lasciando una terra in cui ci hanno accolto molto bene e una bimba stupenda. Non voglio descrivere l’internat (orfanotrofio) perché da fuori fa venire il magone, mentre una volta dentro vedi le dade che si impegnano e comunque ha la sua dignità.
Secondo l’iter dovremmo tornare in Siberia dopo tre-quattro mesi. Cominciamo a scalpitare. Nel frattempo ci teniamo in contatto con la bambina attraverso telefonate appoggiandoci ad un’amica russa. Tutto intervallato da decine di visite specialistiche con medici che chiedono le ragioni di tanti controlli quando la nostra salute è ottima (vagli a spiegare che è obbligatorio per l’adozione).
I quattro mesi di attesa passano ma niente. Richieste di ulteriori documenti (ne abbiamo fatti oltre cento con vidimazioni in Comune, apostille in Prefettura – scritte in blu, non in nero… -, passaggi dal notaio). Via un altro mese, io e mia moglie siamo a pezzi: la bimba è in colonia e non la sentiamo da 6 settimane. Finalmente ci riusciamo ed è quasi peggio: la sua voce non è più quella di prima, è chiaro che non crede più che andremo a prenderla.
Il tempo passa, io sono a terra mentre mia moglie allevia il calvario con pezze di pragmatismo. Con tre mesi di ritardo, arriva la comunicazione del tanto agognato secondo viaggio. A fine novembre si riparte. Lo scoglio ora è rifare in loco tutte le visite mediche ma soprattutto l’udienza col giudice russo che dovrà dare l’ok all’adozione. Ritroviamo la bambina e l’incontro è molto più snello: lei è già più grandina e l’impatto emotivo è meno squassante. Riusciamo anche a non tracollare presenziando alla recita domenicale nell’internat (tale e quale alle nostre, solo senza genitori) con un ottantina di bambini che ci guardano tutti.
Davanti al giudice mia moglie è bravissima, infila anche un discorso in russo di tre minuti (non ne capisco niente). Io invece, appoggiandomi all’interprete, la butto sull’emotivo e racconto la storia di mio babbo nella Guerra di Russia (nel ’42), che durante la ritirata crollando esausto, come molti altri, a terra nella neve, fu soccorso da contadini russi che lo misero in salvo nella loro stalla.
La sentenza è ok, tutti a brindare, ma non c’è più tempo: noi dobbiamo ritornare in Italia e lei purtroppo all’internat. Dobbiamo solo attendere che la sentenza vada in giudicato e tornare in Siberia in pieno inverno, a gennaio, per portarla finalmente a casa con noi. Passiamo le feste di Natale in un turbinio di preparativi, dalla cameretta al necessario da mettere nella sua valigia (chissà come sarà per lei, al telefono ci pare tranquilla).
Ripartiamo dopo la Befana con bollettini meteo che parlano di -40°C. Invece il tempo ci viene incontro e troviamo solo -27°C. Dormiamo una notte in aereo, poi in treno per andare nel paesino a prenderla, poi di nuovo in treno attraverso la Siberia per tornare a Novisibirsk lasciandoci alle spalle il suo mondo. Cosa penserà?
Ora siamo tutti e tre in albergo, distrutti ma carichi. Non c’è tempo, ripartiamo per Mosca con il suo passaporto e lei ha già il mio cognome. Servono i visti consolari e l’accettazione adottiva dall’Italia. Passano tre giorni che paiono anni, giriamo per Mosca come zombie, perché non è il turismo che ci interessa: i nostri rapporti con la bimba sono finalmente di giornate intere e cominciamo ad interagire (nonostante lei parli solo russo).
Finalmente l’aereo per l’Italia, arriviamo a casa emozionatissimi. Impatto buono: la casa le piace e soprattutto la sua nuova camera. Alle 21 va a letto, è cotta. Io e mia moglie ci guardiamo e sappiamo che è partita una nuova vita. Quasi quattro anni dopo averlo deciso, dopo spese che non ci aspettavamo così alte, e dopo 50mila km tra aereo, treno e taxi. Sarebbe necessario snellire il percorso adottivo e contenerne i costi: diversamente il trend continuerà a diminuire. Il 2012 ha visto ridursi del 20% dall’anno prima le domande di adozione complessive in Italia.
Tornando a noi è la spesa emotiva che ci ha piegato le ginocchia in questi anni. L’arrivo della bimba però ci ha raddrizzati in pieno. Non saranno tutte rose e fiori, arriveranno problemi come quelli di tutti i genitori con i loro figli, naturali o meno. Dobbiamo ringraziare parenti, amici e non solo che ci hanno sempre sostenuto durante questo percorso, oltre all’accompagnatrice che ci ha seguito in Russia.
L’ultima parola che mio padre mi disse dopo che gli parlai dell’adozione, che per lui valeva una storia, fu russo. E io avevo già capito tutto.
 Quando voglio darmi arie da esperto, io la chiamo at, ma in Italia è più nota come chiocciola o chiocciolina. Oggi i grafici ne abusano, è utilizzata come segno di tecnologia e modernità. Se in un logo scrivono c@ffè invece che caffè, significa che quello è un bar per nativi digitali, con il wi-fi gratis e tutto il resto…
Quando voglio darmi arie da esperto, io la chiamo at, ma in Italia è più nota come chiocciola o chiocciolina. Oggi i grafici ne abusano, è utilizzata come segno di tecnologia e modernità. Se in un logo scrivono c@ffè invece che caffè, significa che quello è un bar per nativi digitali, con il wi-fi gratis e tutto il resto…